Roma, 22 settembre 2025. La revisione dei conti nazionali corregge verso l’alto il 2023 e consolida il quadro del 2024: domanda interna in lieve risalita, industria ferma, gettito in crescita.
Nel pomeriggio, a Roma, l’Istat ha comunicato un aggiustamento chiave: la crescita del Pil 2023 sale a +1%, tre decimi in più rispetto alla stima di marzo; per il 2024 la variazione in volume resta +0,7%. Numeri asciutti, ma pesanti nei bilanci pubblici e nelle aspettative di famiglie e imprese. Il livello ai prezzi correnti viene ritoccato in alto: per il 2024 il Pil vale 2.199.619 milioni di euro, con una revisione di +7,4 miliardi circa sul dato precedente; per il 2023 l’incremento è di +11,2 miliardi. È un passaggio tecnico che, già lo sappiamo, entra nei calcoli su deficit, debito e pressione fiscale e ridisegna la base statistica da cui partono le prossime scelte di finanza pubblica.
Pil rivisto e quadro congiunturale: cosa dicono domanda e offerta
Il nuovo +1% del 2023 fotografa un’economia che ha corso un filo più del previsto, con una spinta attribuita sia alla domanda nazionale al netto delle scorte (+0,6 punti) sia alla domanda estera netta (+0,1). Nel 2024 il ritmo rimane modesto, +0,7%, ma non arretra: i consumi delle famiglie crescono +0,5% (prima +0,4%), le importazioni si riducono in misura minore (-0,4% da -0,7%), gli investimenti restano a +0,5%, le esportazioni risultano invariate rispetto al lieve segno più della stima di marzo (+0,4% allora). Un equilibrio delicato: la spesa interna regge, il canale estero non aggiunge trazione, la propensione ad investire non accelera.
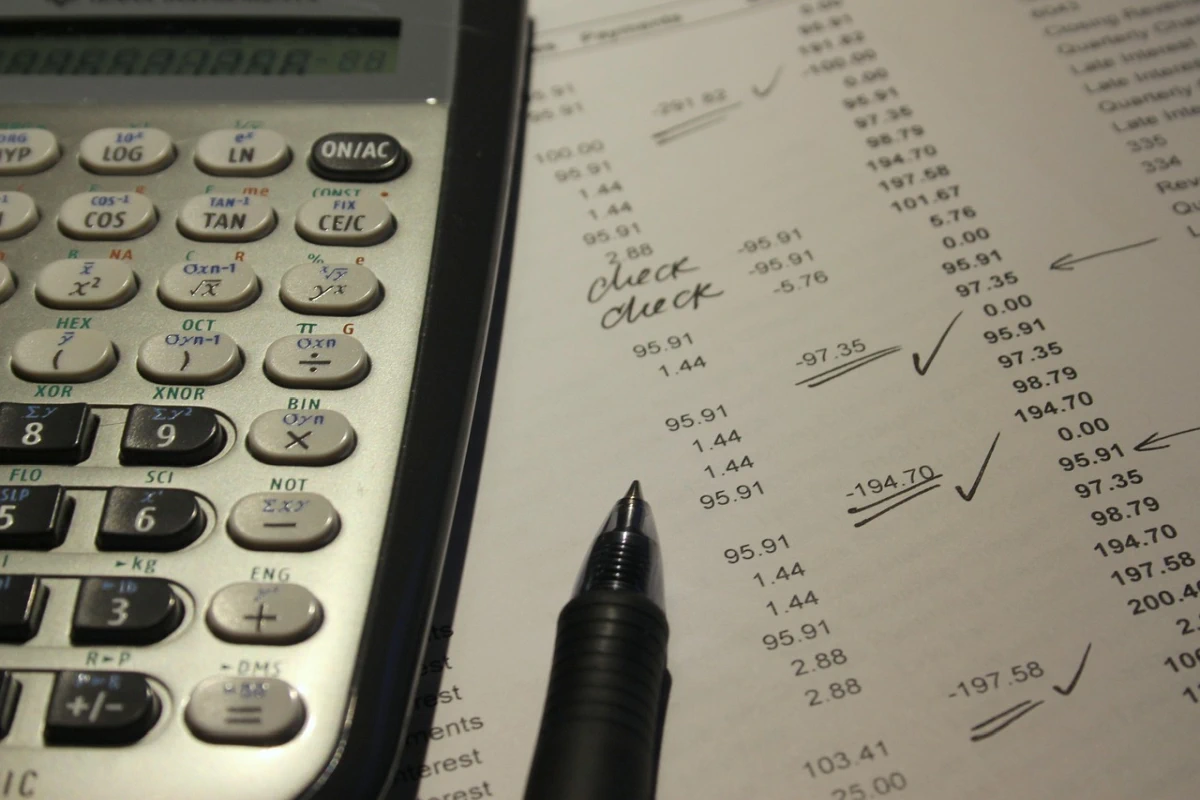
Chi guarda ai settori trova un profilo irregolare: agricoltura +2,0%, costruzioni +1,1%, servizi +0,8%, industria in senso stretto stazionaria. Il mercato del lavoro accompagna il ciclo: cresce l’input di lavoro e salgono i redditi da lavoro dipendente, segnale che l’occupazione tiene e i salari lordi spingono la massa retributiva. È un mosaico senza strappi, con tessere che avanzano a passo corto; eppure, per i conti nazionali, conta: una frazione di punto oggi, un margine in più domani. Sul piano nominale, il 2024 porta la cifra-simbolo: 2.199,6 miliardi di Pil a prezzi correnti, a testimonianza di un’economia che, pur con dinamiche reali moderate, continua ad allargare la base monetaria su cui si calcolano imposte e contributi. Qui entra la parte, diciamo, meno popolare: con entrate fiscali e contributive in aumento +5,8% e un Pil nominale +2,7%, la pressione fiscale sale al 42,5% dal 41,2% del 2023 (leggermente sotto il 42,6% indicato in marzo). Il deficit resta ancorato a -3,4%, il debito scivola da 135,3% a 134,9% del Pil. Non a caso il Mef segnala “soddisfazione” per la revisione del 2023, che alza l’asticella della crescita a consuntivo. Sono livelli che contano nel dialogo con Bruxelles e nelle scelte autunnali di bilancio: una base più ampia può alleggerire rapporti percentuali, mentre l’onere fiscale—lo vediamo—resta alto e visibile nelle tasche.
Impatti su bilancio, famiglie e imprese: perché quei decimali valgono
I decimali muovono miliardi, e i miliardi decidono margini. Con un Pil 2023 più alto e un 2024 confermato in area +0,7%, il quadro di finanza pubblica guadagna qualche respiro: più base imponibile, potenziale spazio—piccolo—per rimodulare spesa o entrate, rapporto debito/Pil in lieve scivolo. La pressione fiscale al 42,5% segnala però un carico che si fa sentire, mentre l’andamento reale invita alla prudenza: senza un salto degli investimenti e dell’export, la traiettoria rischia di restare piatta. Per le famiglie, il segnale misto si traduce in consumi che crescono piano e in potere d’acquisto che dipende ancora da prezzi e salari; per le imprese, la lettura è doppia: domanda interna un po’ più solida, costo del capitale ancora rilevante, mercati esteri non sempre favorevoli. Eppure, proprio perché il 2023 è stato rivisto in meglio, le attese per la seconda parte del 2025 si spostano di un soffio verso l’alto: qualche progetto rinviato può tornare sul tavolo, qualche assunzione si sblocca, qualche asta pubblica diventa sostenibile. Sono dinamiche lente, ma reali.
Roma resta il baricentro della programmazione, con l’autunnale sessione di bilancio pronta a incorporare i nuovi numeri. Il sentiero è stretto: deficit vigilato, debito elevato, fisco al massimo dagli anni 2020-2021. Il tassello positivo è la stabilità, che evita scossoni e sostiene la credibilità del Paese sui mercati. Il tassello mancante è l’intensità del ciclo, da cercare con politiche che alzino produttività e investimenti privati. Intanto, quei tre decimi in più sul 2023 non sono un dettaglio: cambiano la storia recente del Pil e offrono al governo un racconto più solido per gli impegni con l’Europa. Il resto dipenderà da come si muoveranno prezzi, tassi, domanda mondiale. La statistica ha fatto il suo, ora tocca alla politica economica dare spinta—piccola, ma concreta.

