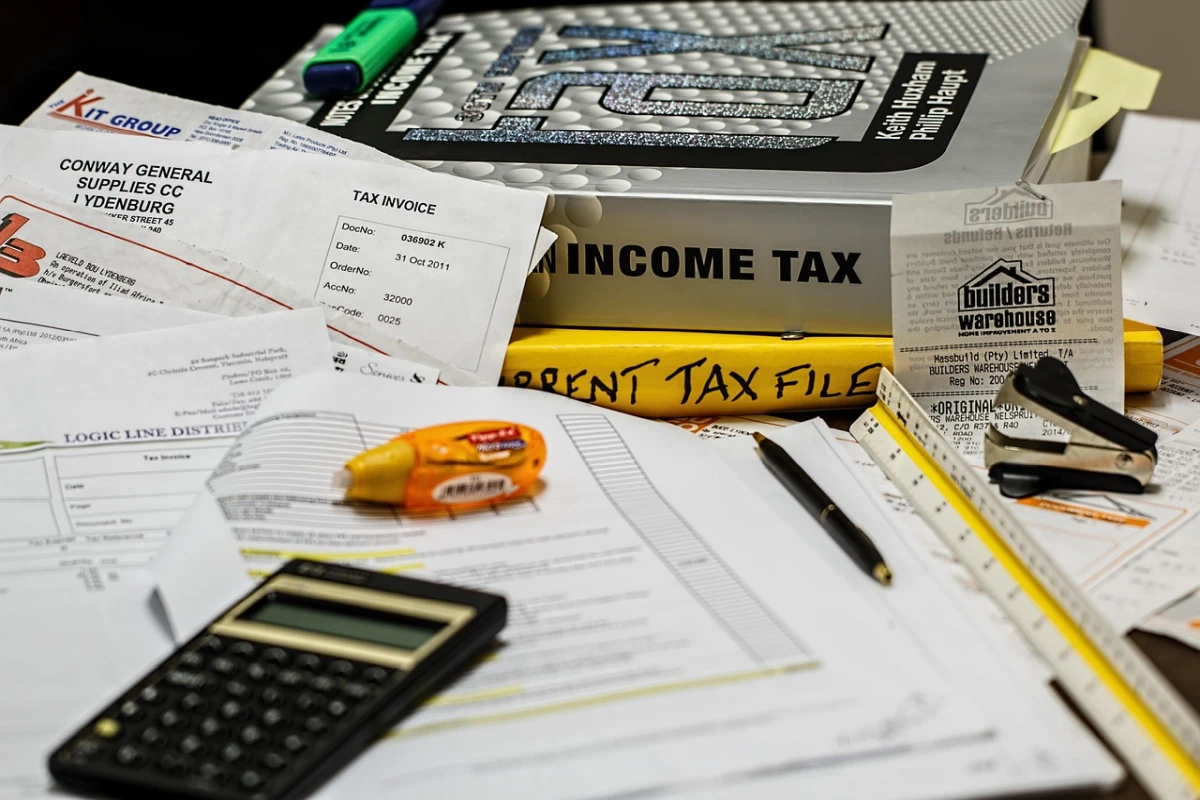L’Istat rileva una stagnazione dei consumi nel primo semestre 2024: le famiglie tagliano spese primarie, mentre cresce la povertà.
Il rallentamento dei consumi familiari in Italia continua a segnare il passo. Nei primi sei mesi del 2024 la crescita si è fermata a un misero +0,5%, una variazione che, a fronte dell’inflazione ancora elevata, si traduce in una contrazione del potere d’acquisto reale. A confermarlo è l’Istat, che nel suo rapporto aggiornato ha messo nero su bianco un dato che preoccupa economisti e associazioni: non solo i consumi non ripartono, ma le famiglie stanno rinunciando sempre più a beni e servizi ritenuti fino a poco tempo fa essenziali.
Un dato in particolare mostra l’allarme: il divario tra le famiglie ad alta e bassa capacità di spesa si allarga, mentre le famiglie più vulnerabili riducono la spesa alimentare, sanitaria e abitativa. Non è una crisi congiunturale, dicono gli esperti: la stagnazione dei consumi ha radici profonde, legate a precarietà lavorativa, stipendi fermi e inflazione ancora troppo alta per i redditi bassi.
Consumi fermi e spesa al ribasso: l’impatto sui bilanci familiari
Nel dettaglio, l’Istat ha registrato che nel primo semestre del 2024 la spesa media mensile delle famiglie italiane si è attestata attorno ai 2.660 euro, con una crescita nominale modesta rispetto al 2023. Ma al netto dell’inflazione, che in alcuni comparti – come alimentari ed energia – ha toccato punte del 6-7%, il valore reale è negativo. Il segnale è chiaro: le famiglie stanno tagliando, e lo stanno facendo in modo selettivo.

I dati raccontano un’Italia a due velocità. Le famiglie con un reddito annuo lordo sopra i 35.000 euro mantengono i livelli di spesa, anzi in alcuni casi aumentano gli acquisti per tempo libero, ristorazione e servizi digitali. Quelle con redditi sotto i 20.000 euro, invece, riducono la spesa per beni alimentari e medicinali da banco, posticipano cure odontoiatriche, e rimandano interventi sulla casa.
Un dato significativo è la crescita del ricorso alle promozioni e al discount, che ormai riguarda anche il ceto medio. Il numero di famiglie che dichiarano di “non arrivare a fine mese” resta stabile sopra il 20%, mentre cresce il numero di nuclei che usano risparmi o credito per coprire le spese mensili.
Inoltre, l’80% delle famiglie ha dichiarato di aver ridotto i consumi energetici rispetto al 2023, non tanto per motivi ecologici quanto per contenere le bollette. La spesa per elettricità e gas è aumentata dell’8%, spingendo molte famiglie a rivedere il proprio stile di vita.
Le cause strutturali: salari bassi e precarietà lavorativa
La lentezza con cui ripartono i consumi è il riflesso diretto di un’economia che, pur non essendo formalmente in recessione, mostra fragilità strutturali. Una delle principali riguarda il livello dei salari: secondo i dati aggiornati, in Italia il salario medio netto si aggira ancora attorno ai 1.400 euro al mese, cifra che in molte aree non copre più il costo della vita.
Il peso del lavoro precario incide sulle scelte economiche delle famiglie, che evitano spese a lungo termine e rinunciano ad acquisti importanti. Mutui, elettrodomestici, auto: tutto viene rimandato, congelato da un clima di incertezza che scoraggia anche i consumi legati al credito.
L’Istat sottolinea che nel 2024 è cresciuto il numero di famiglie mono-reddito, soprattutto a causa della perdita di posti di lavoro nel settore dei servizi. Allo stesso tempo, il tasso di occupazione resta alto, ma si tratta spesso di contratti a termine, part-time involontari o collaborazioni poco stabili.
A contribuire al quadro ci sono anche fattori demografici. La crescita delle famiglie unipersonali, soprattutto tra gli anziani, e l’aumento dei nuclei con figli a carico che vivono in affitto, accentuano le difficoltà.
Infine, non va dimenticato il peso del debito: tra affitti, bollette e rate, la quota di spesa vincolata raggiunge ormai il 60% del reddito disponibile in molte aree urbane. Questo lascia poco margine per la spesa discrezionale, con effetti diretti su commercio e servizi locali.
Povertà in aumento e impatto sociale nei territori più fragili
La stagnazione dei consumi non è solo un indicatore economico, ma un segnale sociale allarmante. L’Istat segnala una crescita della povertà relativa, soprattutto nel Mezzogiorno, dove le famiglie che vivono con meno di 1.200 euro al mese sono ormai quasi un terzo del totale. Il fenomeno tocca in particolare nuclei con minori, disoccupati di lungo periodo e famiglie monogenitoriali.
In regioni come Calabria, Sicilia e Campania, la quota di famiglie che non riesce a sostenere le spese mensili è quasi doppia rispetto al Nord. Aumentano le richieste di aiuto ai servizi sociali, alle Caritas locali, ma anche agli sportelli dei Comuni per ottenere accesso a bonus bollette, sussidi o fondi affitto.
Il calo dei consumi sta mettendo in difficoltà anche il piccolo commercio di prossimità, con chiusure diffuse nei centri urbani medio-piccoli, mentre nei grandi centri crescono i consumi solo nei segmenti premium o nei quartieri più ricchi. L’effetto è una polarizzazione sempre più marcata del tessuto economico locale.
Le associazioni che si occupano di tutela dei consumatori parlano apertamente di un rischio concreto: quello di una frattura sociale destinata ad allargarsi nei prossimi mesi se non ci saranno misure strutturali. La debolezza dei consumi, insomma, è lo specchio di un’Italia che si sente più povera, più sola, e sempre più distante da una vera ripresa.